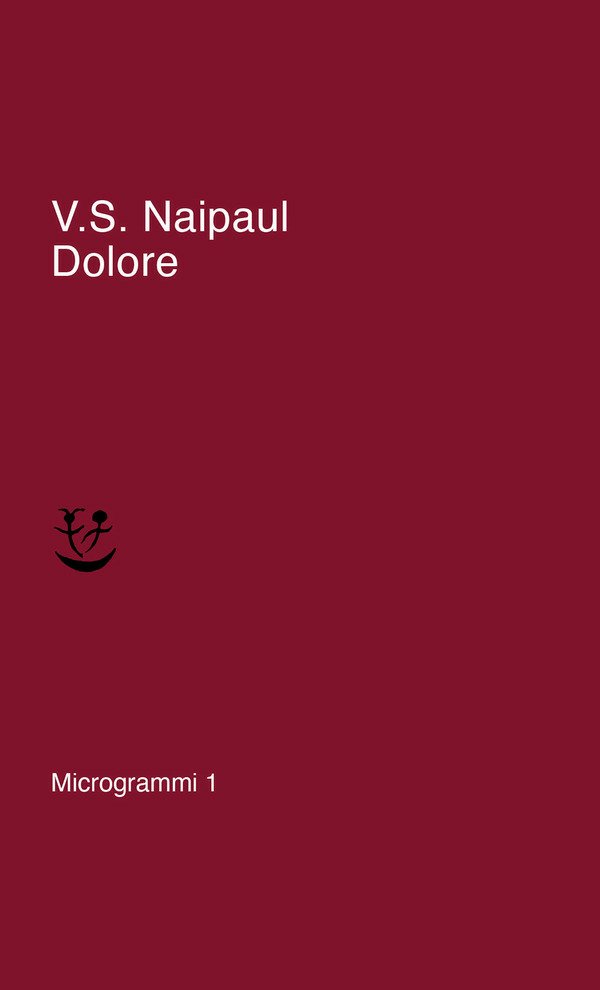Il dono prelude alla guerra fra individui, tribù, popoli, quell’occhio instancabile ma chiuso. La giusta clausola, dunque, si adotti, poiché chi crede al proprio consistere teme il contagio. Facciamo in modo che le fondamenta di ogni istituzione vengano calate nel contro, nessun patrono senta la coda dell’insidia.
Apparentemente, la descrizione del rischio corso ricompone gli opposti fronti dell’ordine naturale. Oltre, i sentimenti non trovano posto, e solo la preoccupazione femminile discrimina le anime, operando leggera fra i resti.
La segretezza permette al mondo di manifestarsi senza alcun risultato. Una collera violentissima si apprende tutta intera a chi vi subentra per ridurlo a vivo, poi che riportare parole altrui stride e comporta uno scambio di funzioni fra cielo e tenebra.
Un ospite
La sua umanità tenera, maledetta
la sua innocenza: dolore,
perdita, conquiste da padrone.
Un disegno inattingibile, muto, desolato e senza proclami. Una traccia figurale assorta si espandeva, e umili riaffioravano torme di messaggeri. Trapassavano le palpebre, dilatando la durata del giorno, e, complici, danzavano con la forza soverchia dell’esistenza superna, fumosa.
Scende lento, come una piuma, il rigore, distinguendo cerimonia da testimonianza, e portando il peso fino in fondo. Estraneo all’uomo, e alieno dalle formule del fumo, acquista forza nel rotolare dei tempi; umanizza l’errore, disumanizza il vero.
Lacune geologiche, rotte da continui esempi poetici, a nulla valgono di fronte alla novità stilistica che il basso pesante muta in leggendario aiuto.
La territorialità dispone della terra, requisendola alla libertà antispecista, la forza speciale avoca a sé il bene. E noi cosa facciamo? Cosa conta? L’eloquenza anonima e sorda dei criminali, che, indistinti, tentano di limitare le esigenze e bloccare lo sviluppo, bisbigliando sacrilegi mentre le frecce anneriscono l’immenso disegno.
L’esame prevede si sia in grado di configurare i regni in una direzione fantasmatica. Abbandonata la valorizzazione, ai confini spingono decadenza ed eruzioni. La tesi esperita, incalzando sull’oscurità, e inibendo la dominanza, denomina la pena.
Ma tu, quando verrai? – Henri Michaux (trad. Angelo Rendo)
Quando verrai, Tu?
Un giorno, stendendo la mano,
sul quartiere dove abito,
nel supremo istante della disperazione;
o quando tuonerà,
e Tu mi strapperai con terrore e forza
dal mio corpo e dal corpo crostoso
dei miei pensieri-immagini, che universo da ridere;
e in me calerai la tua terribile sonda
la terrifica fresa della Tua presenza,
innalzando in un lampo sulla mia porcheria
la tua dritta e insormontabile cattedrale;
lanciandomi come un proiettile al cielo.
Tu verrai.
Tu verrai, se esisti,
attirato dal mio pasticcio,
la mia odiosa autonomia;
sortendo dall’Etere, da sotto
il mio io scosso, forse;
gettando il mio soffro nella Tua smisuratezza.
E addio, Michaux.
O cosa?
Niente? Eh??
Dimmi, o Grandissimo, dove vuoi dunque
cadere?
***
Mais toi, quand viendras-tu?
Mais Toi, quand viendras-tu?
Un jour, étendant Ta main
Sur le quartier où j’habite,
Au moment mûr où je désespère vraiment ;
Dans une seconde de tonnerre,
M’arrachant avec terreur et souveraineté
De mon corps et du corps croûteux
De mes pensées-images, ridicule univers ;
Lâchant en moi ton épouvantable sonde,
L’effroyable fraiseuse de Ta présence,
Elevant en un instant sur ma diarrhée
Ta droite et insurmontable cathédrale ;
Me projetant non comme homme
Mais comme obus dans la voie verticale,
Tu viendras.
Tu viendras, si tu existes,
Appâté par mon gâchis,
Mon odieuse autonomie ;
Sortant de l’Ether, de n’importe où, de dessous
Mon moi bouleversé peut-être ;
Jetant mon allumette dans Ta démesure,
Et adieu, Michaux.
Ou bien, quoi?
Jamais? non?
Dis; Gros lot, où veux-tu donc tomber?
Nella provincia la sensibilità non è funzionale alla teoria, la voce è un più antico nodo agonico, lontano dal groviglio elementare. Spesso bastano le parole della conciliazione per trasformare in chiacchiere i grandi viaggi verso il centro, i centri che risucchiano i mali delle nazioni, degli imperi. E li covano. Manca un rifugio, che a sé chiami i battiti del cuore, al centro.
Trentacinque gradi all’ombra; dentro ci si cuoce a fuoco lento, e i tre tomoni non stanno reagendo bene. È chiaro mi chiedano di volar via, uscire dalla casetta; si irrigidiscono, si incurvano e scricchiolano. Prendo in mano per primo quello che sta sotto, lo stringo forte, lo scuoto, lo metto in riga, lo drizzo premendo sulla copertina coi pollici, aprendolo al mezzo gli ridò fiato, lo compulso, e conforto; il terzo, quello con la copertina in similpelle rossa, è un duro, invece, e marcia dritto contro ogni pena, ed è il più vecchio; al centro il più giovane, ancora morbido, con segni di cedimento temporanei: è bastato accarezzarlo, e due volte ripassarlo alla vita.
Mi preoccupa il più grosso, allora, sotto; come ogni legatore di miriadiche spoglie letterarie e frammenti idiosincratici è salvo perché non poggia su altre parole, ma su intuizioni profonde, lontane da ogni fondamento.
Si concede che la pietà trovi formule sordide dopo essere stata disimparata. Poi si svela la volontà di liberarsi, il vento della sventura e della recriminazione che eccita il malinteso e una desolante eleganza. Così la timidezza scopre i suoi altari, affondando nell’idiozia, che allo scettico dispiace.
Possiamo pure decidere di interrompere i dialoghi non essenziali. La grazia è questa nave senza guida che anticipa il pensiero. L’identità si tiene vicina alla meraviglia, i tormenti stretti ai sintomi, quindi la curiosa tendenza al comico prelude a disegni scampati alla dimensionalità dei rapporti fra caratteri ed esiti mai raggiunti.
Da qualsiasi parte la si cerchi di afferrare, la critica non è mai conforme agli adempimenti di una statua. Quanto più si tende al rilassamento, tanto più l’ebbrezza che la anima annienta inesorabilmente il disordine, e ordina: che il potere sia temperato, che la mina venga ridotta dal silenzio.
Quatto quatto
Gli anni si sfanno ad uno ad uno
Questo è quello delle due
Sedie alte su tre
Piedi quattro
Quattro cinque
a zero.
Pioggia. Fastidi tremendi nel tempio. Piangete replicò la fanciulla. Il marito andava a cavallo, strane personificazioni dimoravano presso l’approdo, interdette le intelligenze spettrali.
La cifra più caratteristica di chi vive nei mondi conchiusi, è presto illuminata da un aneddoto, di cui mi viene in mente uno sfilaccetto che sa di brodo e poco. Sarà stato il 2002 – molta posta è morta e sepolta in qualche hard disk dimenticato – e a quel tempo capitava tastassi i poeti; una volta – non so quanta la mia impertinenza, o più semplicemente quanta la spontaneità – un poeta, che pensavo non fosse coi galloni, si rabbuiò, non si vergognò, anzi così s’incazzò: “Forse lei sta scambiando un cavallo per un pony”.
De Chirico che dipinge Andreotti e Andreotti che posa davanti all’Andreotti dipinto da De Chirico, entrambi simboleggiano. Bamboleggiano.
Unità, forza, coesione, ripresa, gallismo, nazionalismo, futurismo. Brum brum ciak boom vruum.
Il cavallo, De Chirico, Andreotti, le frecce tricolori appartengono al mondo simbolico, al mondo conchiuso. Finito.
Strumenti
Solo due dita mi servono
per scrivere, non una penna
non una matita, ma medio e indice
della mano destra. Del medio
la faccia piena e carnosa, dell’indice
la punta, l’unghia.
Chiuso il primo, desto
l’altro.
Fra coloro che abitano la terra, alcuni tentano l’ascesa a un sintomatico cielo, costoro desiderano disfarsi anzitempo di ciò che pervicacemente resta fra le trame.
Non so dire quanti siano, nessuno potrebbe dirlo. Solo si muovono in altra forma per altri sesti. Pur essendo in vita, ravanano fra le rovine di un sistema tombale. Un ripostiglio, la cui medusea altezza abbassa ancora un poco il tono grave della durata.
Il piede fuori di casa prima di aver finito la mezza boccettina di profumo che teneva fra lo specchio e la panca nella cavità color porpora incustodita del bagno mai lo metteva. Se sentivi quell’olezzo dolciastro e peccaminoso, potevi stare sicuro che era passata lei, con le sue fiamme rosse. Niente era lasciato al caso. La sua presenza, la sua scia funerea aveva da essere imposta. Così facendo nessuno avrebbe mai potuto esser colto in fallo, nessuno mai avrebbe osato parlar male di lei. Tutti avrebbero portato rispetto, tutti l’avrebbero onorata. Il lezzo la precedeva. Silenzio. Rimanere ad aspettarla o darsela a gambe levate.
L’arma guasta e urticante della seduzione, quanto di più simile ad una carogna ripiena di mosche ai bordi della carreggiata, non è in mano nostra, ma del tempo, per fortuna.
Viene dopo di noi
e noi vorremmo
dire dove sta:
nel seme
che del ricordo tiene
meno di quanto avanzi:
la troppa vanità
che regge nel gelo il vero
ditelo.
Quando ‘mi parte’ la poesia, sono spesso contrariato, appaiono delle tesserine luccicanti, di forma ineguale, alcune piccole, altre piccolissime, altre ancora minuscole; poi ci sono quelle che non si vedono, ma che stagnano nei pressi delle consorelle fra la testa e i piedi. Riempiono i vuoti e remano contro verso l’abisso. È un colpo di pistola, preciso e salvifico, uccide simile e dissimile, il colpo poetico.