“Ma prossima è la morte a una immortale
Vita, chiusa la falsa, apre le porte,
Vita di vita e morte della morte.
Chi gli agi fugge per amar naufragi?
A chi, più del riposo, il viaggio piace
E il lungo errare è più dolce del porto?”
Franco Fortini
“ma l’impegno è doppio la fatica è dura il rischio
è alto e nel vissuto vive (e nel vivere vivendo
continua a vivere e a morire) e morendo vive
fa un giro pieno ma senza tempo si fa presente
e con il dono alto di chi ha capito…”
(p. 84)
La nuova raccolta di Luciano Neri, dopo l’esordio visivo in ricognizione di un reale frantumato rappresentato da “dal cuore di Daguerre”, espone la parola poetica ad un tour de force itinerante che, proseguendo sulla scia del libro precedente, trasporta verso la maturazione che una perdita di rotta, ontologica in senso pieno, linguistica in rapporto allo strumento utilizzato, possa condurre ad una inedita definizione del reale stesso.
Le premesse tematiche di tale operazione, sono esplicitate da un denso approfondimento filosofico e da una riflessione costante sul pensiero debole tardonovecentesco e dalla domanda capitale sulla effettiva valenza, vista la scomparsa di paradigmi di riferimento etici, dello strumento verbale all’interno delle mutazioni antropologiche in atto nella contemporaneità.
Nel quadro quasi asfissiante di una quotidianità viziata dalla continua riproducibilità e ripetitività degli eventi, dal luogo-non luogo dei social network, finestre aperte sull’incapacità di contatto e celle di clausura di una vita sociale spinta in direzione di un voyeurismo neutralizzante, al luogo altrettanto asfittico dell’informazione veicolata e per questo trasformata in show di propaganda unidirezionale e inibente qualsiasi dibattito, la lingua poetica tenterebbe di violare, in senso spaesante e in assoluta solitudine, il circolo vizioso della spersonalizzazione attraverso una nuova articolazione della scena relazionale. Alcuni libri significativi in questa direzione sono stati recentemente pubblicati, si pensi a “L’attimo dopo” di Massimo Gezzi o a “Bambino Gesù” di Daniele Mencarelli i quali, con scelte stilistiche diversificate, si affiancano a “Lettere nomadi” nello stabilire nuovi scenari d’azione in cui la poesia riesce a manifestare la sua vitalità e forza di opposizione all’imperante confusione di riferimenti etici e all’annichilimento delle dinamiche di relazione.
Il concetto, o parola chiave, sotto il cui segno queste prove poetiche possono essere accomunate è “apertura”, apertura verso un “altro” che contribuisce a definire l’individuo attraverso l’attivazione di un ascolto dis-tratto nella necessità del viaggio, metafora per una potenzialità di movimento che potrebbe portare all’incontro: “poi venne il moto spostando i corpi/ nella brezza e il racconto sulle ossa/ galleggianti una presenza oscura,/ una parola detta, non detta, l’estremo/ dono” (dalla sezione “Ultime notizie”, III, vv. 8-12, p. 12). Ed è la dimensione cinetica, che collegandosi strettamente alla tematica dell’offerta gratuita, del “dono” appunto, ad esibire in tutta la sua valenza la possibilità dell’oscillazione tra partenza e ritorno. Le scelte sintattiche delle prime sezioni manifestano proprio questa tensione oscillatoria in cui i referenti si confondono nella trama dei versi, e soggetti e oggetti si mescolano sulla scena del singolo componimento fino a scomparire rendendo protagonista la stessa scena e quindi il suo movimento: “occhi spostati da sibili/ frangivento archi alla foce/ delle grotte sul povero/ costrutto dei corpi, aria/ levitata dalla terra e virtù// di una grazia sconfinata/ ma senza gravità la caduta/ senza rumore disperso” (“(guerra civile)”, vv. 11-18, p. 24).
La dispersione, come altro concetto fondante del viaggio, insieme alla possibilità provvisoria dell’orientamento nel contatto, contribuisce a chiarire l’inedita situazione in cui viene a trovarsi la lingua – protagonista del libro, realtà sottesa all’ulteriore metafora del naufrago-viaggiatore, il poeta stesso che metonimicamente è il suo sistema verbale – consistente nel movimento sempre più incalzante e fluttuante tra dispersione e orientamento, appunto. Se viene corso il rischio del salto nel buio del viaggio, questo movimento apre in potenza un campo, uno spazio dalle molteplici possibilità ed evenienze, una nuova costellazione di comunicazioni svincolate dalle identità aprioristicamente definite e perciò refrattarie al dialogo: “lo spazio si nutre più del campo aperto/ che al movimento – fugge la chiarezza/ benché la memoria sia un sasso” (dalla sezione “Pagine controluce”, p. 28). Ma le stesse potenzialità sono quasi attenuate dal carattere frammentario dei dati raccolti (i testi di “Lettere nomadi”, non dimentichiamolo, sono presentati come schegge di corrispondenza: “uno scarto […] grazie al quale sperare per una destinazione”, p. 97), e forse è proprio questa poetica del “minimo” (lo scarto, il truciolo mi verrebbe da dire), della possibilità nel residuo a trincerare nella speranza, nell’aspirazione assidua, il significato della raccolta. Nel racconto frammentato non sembra essere velata una semplice indecisione tra l’ampio respiro della narrazione in versi e la clausura, comunque vivificante, del sospiro lirico (con tutte le potenzialità che il dialogo lirico può aprire ri-attivando intimamente la dinamica di relazione), piuttosto l’acquisizione di un mestiere che, rimodulando i suoi strumenti, tende a eliminare definitivamente ogni distinzione, ed attivando, anche sul piano stilistico, una possibilità comunicativa tra micro-evento (il singolo componimento) e macro-evento (il viaggio-trama).
L’apertura comunicativa, se si accetta la lettura appena abbozzata di uno stile che tenti un cammino spiazzante all’interno della classificazione dei generi, è il riflesso psicologico di una volontà inoperosa che svuotata dalla necessità della scelta potente diviene scelta della necessità impotente; come dice Agamben: “questa potenza o possibilitazione originaria ha […] costitutivamente la forma di una potenza-di-non, di un’impotenza, in quanto può soltanto a partire da un poter non, da una disattivazione delle singole specifiche possibilità fattizie” (G. Agamben, “L’aperto, l’uomo e l’animale”, Torino 2002, p. 70).
Non potendo fare a meno di disporsi alla sua necessità la lingua appronta il teatro veritiero della sua stessa apertura: la presenza nella concretizzazione della sua assenza sempre falsificabile e per questo modificabile: “scrivendo cambio pelle/ rimanendo presente in ogni/ momento della vita separabile/ in un lampo e lì metto a punto/ il necessario per i compagni/ destinati al cammino su alture/ imprevisti.” (dalla sezione “Sosta ad Exharĭa”, V “(margine per lo scrivente)”, vv. 1-7, p. 67). Nella nuova dimensione di necessità impotente all’apertura, la metafora del viaggio acquista e fa acquistare alla poesia nuovi confini e coordinate nella stessa fine della possibilità di orientamento; l’ultima sezione del libro “Fine del ritorno” sembra suggellare, per un attimo breve, una stagione che rimane divaricata sulla propria eternità attraverso le tappe di un cammino mai nato, sull’orlo di un’esistenza che ha da sempre compiuto il passo iniziale in direzione della sua stessa impossibilità, impossibilità, appunto, del ritorno ad un qualsivoglia luogo di partenza: “il confine è quello che non ha nome e dorme in chi lo ha perduto/ e vive nell’altro che ha trovato morto appartato e in ogni madre vive/ e in ogni uomo secondo distanze lontananze avanti indietro in bagliori/ nel bisbiglio di chi si ferma in quell’immagine persa percorrendo pupille/ distratte senza carta ma ferisce più lì o se ferisce perdona” (dalla sezione “Fine del ritorno”, III “(a M.)”, p. 95).
Sull’espansione del viaggio senza fine di una lingua aperta al suo vagabondaggio, così come sui versi ormai irriconoscibili per dimensioni e sviluppo sintattico, “Lettere nomadi” si chiude, sintomaticamente senza un punto fermo, estendendo a noi lettori l’orizzonte vastissimo e ormai libero della sua instabilità.
Febbraio 2011
Gianluca D’Andrea

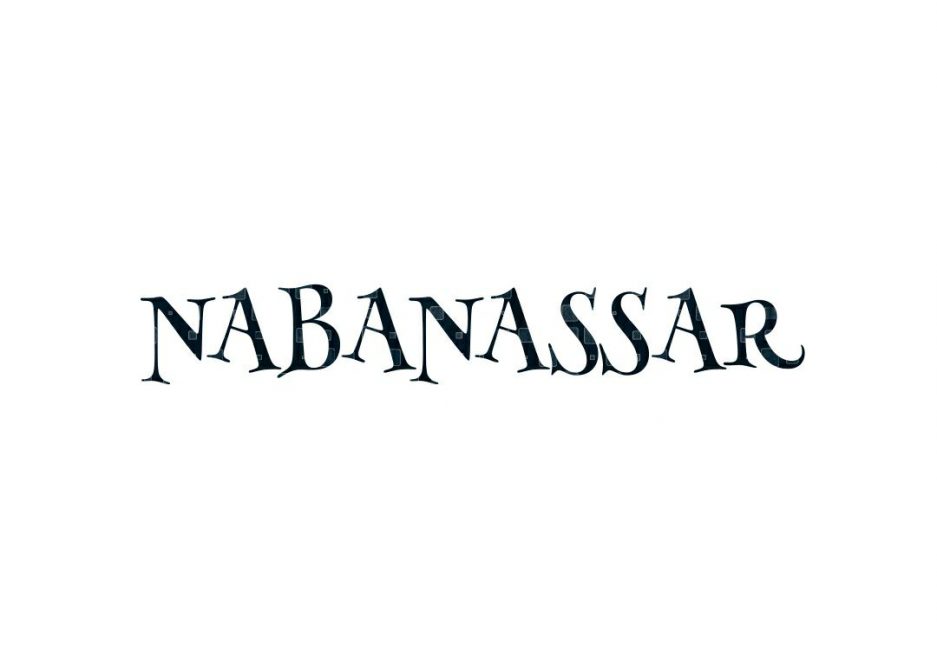
Più che una recensione, una nota critica dall’interno dei testi, di cui ricostruisce ordito, trama e risonanze – ben pensata e ben scritta, bella ed esauriente.
Complimenti Gianluca, e grazie, mi procurerò il libro.
fm
Bentornato Gian, salutami Luciano Neri: lo incontrai una volta alla stazione di Pisa una decina di anni fa e scambiammo due chiacchiere. Ricordo il suo berretto e una ammirazione per Frasca che -a leggere le tue note- non pare gli abbia impedito di sviluppare un suo discorso personale.
bentrovati francesco e peppe, torno per un attimo e poi scappo. Questo periodo, stagione della mia vita, richiede tempo e impegno, quindi restano poche parentesi da dedicare alla lettura; trovo un po’ di spazio e leggo pagine illuminanti anche per la mia ricerca: Lettere nomadi è lo splendido tentativo di apertura di quell’uomo di confine che Luciano è (la voce minima e espansa di Genova in tutte le sfaccettature di una tradizione che ha vissuto sulla propria pelle tutte le oscillazioni). Ora mi muovo sul territorio lombardo, Corpo Stellare di Pusterla è un ottimo libro e mi spinge nuovamente a Sereni (attraverso Buffoni), ne scriverò a breve.
p.s. Caro Francesco, potremmo far passare la mia lettura di Lettere Nomadi su La dimora del tempo sospeso, fammi sapere, un abbraccio
Gianluca, ci avevo già pensato e volevo chiedertelo io. La settimana prossima la ripubblico con molto piacere; vedi se nel frattempo ti è possibile farmi avere qualche testo, non ho ancora il libro.
Aspetto tue nuove.
Ciao, un abbraccio.
fm
Ok Francesco, in serata ti faccio avere qualche testo, ora ti abbraccio (mando via mail)